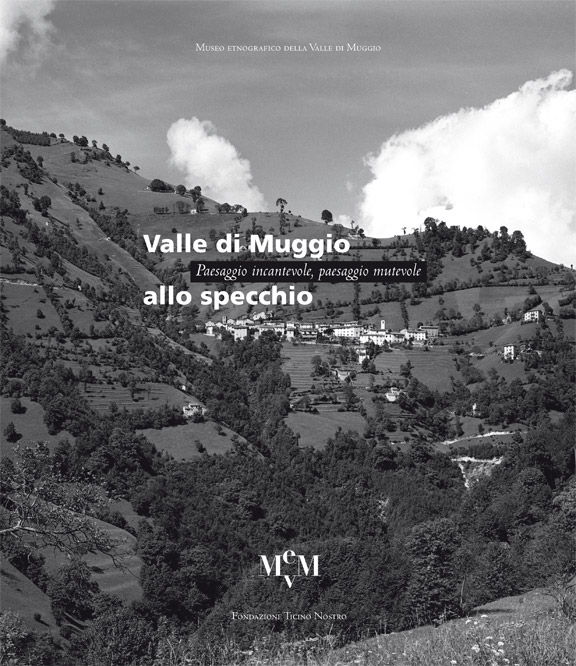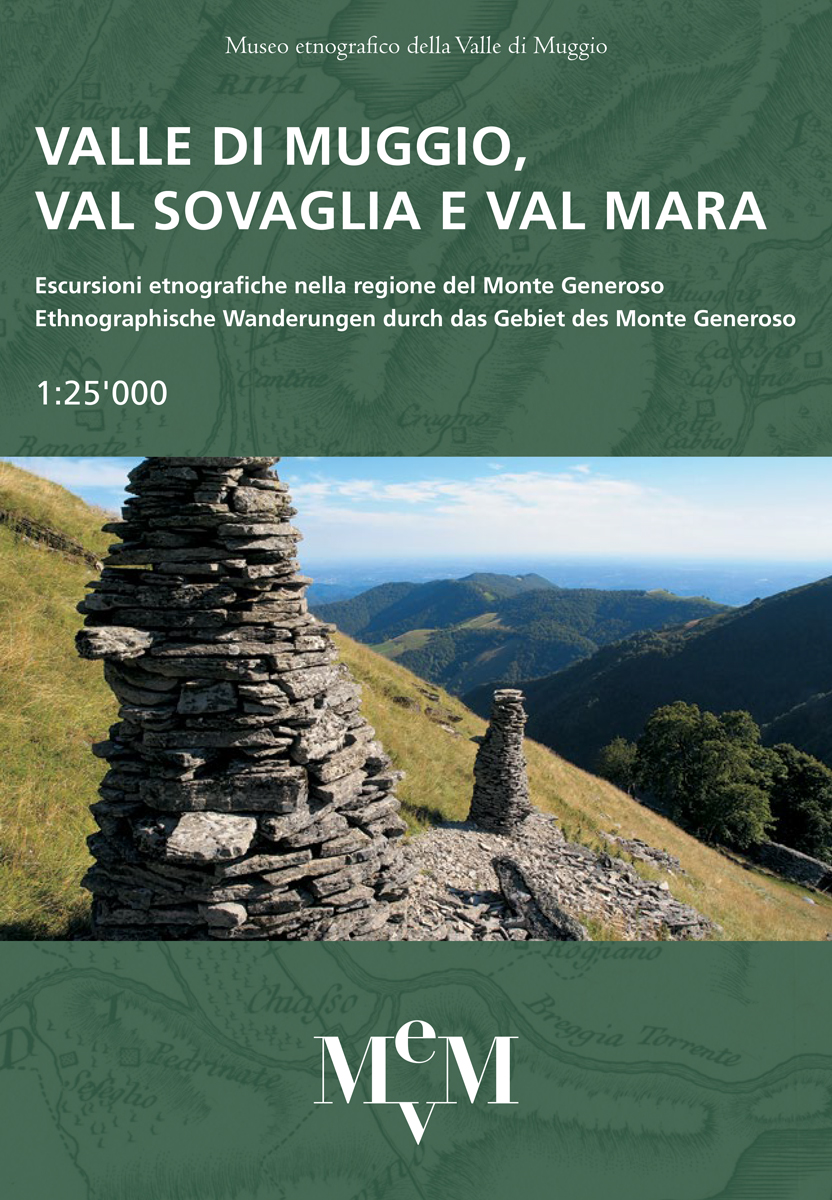Bolle

Gli occhi della montagna
In un ambiente caratterizzato dal fenomeno carsico la scarsità di acqua di superficie rappresenta un problema per uomini e animali. Con la diffusione dell’allevamento alle alte quote si è reso necessario trovare un metodo per sopperire all’assenza di fonti permanenti specialmente nel periodo estivo e autunnale dell’alpeggio. Un metodo praticato da secoli è quello di creare degli abbeveratoi a cielo aperto per gli animali costruendo apposite conche nel terreno che si riempiono di acqua durante i periodi di pioggia. All’apparenza ricordano piccoli laghi o pozze di forma arrotondata e sono conosciute col termine di bolle. In realtà, si tratta di opere artificiali, scavate dall’uomo solitamente alla base di un pendio dove una sorta di diga trattiene l’acqua. Per migliorare il riempimento viene scavato un canale trasversale al pendio in modo da convogliare l’acqua piovana all’interno della bolla. Generalmente sono poco profonde, al massimo un metro. La condizione fondamentale per assicurarne il funzionamento è l’impermeabilità del fondo per cui anche la bolla esige delle cure particolari. L’operazione di manutenzione del fondo va ripetuta regolarmente distribuendo del materiale argilloso. Si usava anche gettare della cenere. Per compattare il fondo, esso veniva battuto con un apposito attrezzo composto da un tronco alto circa un metro e dotato di un manico: veniva afferrato, alzato e fatto cadere a terra. Un altro stratagemma consisteva, quando la bolla era vuota, nel gettare qualche manciata di sale per attirare i bovini all’interno; il ripetuto calpestìo del fondo da parte degli zoccoli lo rendeva impermeabile. La bolla doveva essere spurgata saltuariamente e doveva essere mantenuta libera dalla vegetazione.
In Valle abbiamo inventariato una trentina di bolle situate principalmente nella zona degli alpeggi. L’Alpe della Bolla conserva l’impronta di una bolla storica in quanto rappresentata sulla mappa ottocentesca di Cabbio e anche già citata nel XIV secolo. Due bolle si trovano nella selva castanile di Caneggio indicate sulla mappa ottocentesca come Bozzone vecchio e Bozzone nuovo.
Alcune di queste bolle sono ancora in funzione sul Barco dei Montoni, gli alpi di Orimento e sul versante del Monte Crocione. Sui versanti del Monte Generoso rimangono le impronte di alcune bolle ma sono asciutte in quanto, con la costruzione dell’acquedotto, sono state sostituite dalle vasche da bagno.
Tratto da: Crivelli, Paolo e Silvia Crivelli, "Il territorio", in Valle di Muggio allo specchio. Paesaggio incantevole, paesaggio mutevole, a cura di Paolo e Silvia Crivelli, MEVM ; Fondazione Ticino Nostro, 2017, pp. 166-239.

"Attualmente in Valle di Muggio si contano una trentina di bolle, ognuna con le sue particolarità faunistiche. Le bolle che si susseguono lungo la strada sterrata che dal Dosso dell’Ora conduce al Dosso Bello, per esempio, richiamano in primavera una miriade di anfibi per la riproduzione. A fine marzo, non appena a i tiepidi raggi di sole primaverile sciolgono lo strato di ghiaccio che le ha ricoperte durante l’inverno, arrivano le Rane temporarie (Rana temporaria) e le Salamandre pezzate (Salamandra salamandra). Seguono poi il Rospo comune (Bufo bufo), il Tritone crestato meridionale (Triturus carnifex) e in maggio-giugno la Raganella italica (Hyla intermedia) che qui forma una delle popolazioni a maggior quota nelle Alpi. [...]
Per proteggere adeguatamente questa ricca diversità di anfibi, che conta ben 5 delle 12 specie presenti in Ticino, le bolle tra il Dosso dell’Ora e il Dosso Bello sono inserite nell’Inventario dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale. L’iscrizione in un inventario non è però sufficiente a garantirne la salvaguardia a lungo termine. Le bolle infatti sono ambienti assai sensibili e richiedono una costante manutenzione che ne assicuri l’impermeabilità. Se in passato esse venivano curate regolarmente dagli alpigiani, la costruzione degli acquedotti le ha rese superflue. Oggigiorno sul versante svizzero la loro gestione, garantita dall’Ufficio natura e paesaggio (Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino), avviene perlopiù per scopi naturalistici e paesaggistici.
Un altro gruppo di specie che in Valle di Muggio ha trovato ambienti favorevoli grazie alle bolle costruite in passato, è quello delle libellule. Come gli anfibi, anche le libellule per la riproduzione sono strettamente legate all’acqua. Questi insetti trascorrono la maggior parte della loro vita in uno stadio larvale acquatico, la cui durata, a dipendenza della specie, varia da pochi mesi fino a 5 anni. Con la metamorfosi si trasformano poi in insetti adulti alati, sovente dotati di un volo possente che consente loro di colonizzare anche ambienti discosti e isolati. [...]
Ad abbeverarsi alle bolle giunge regolarmente pure una folta schiera di abitanti notturni che solitamente passa completamente inosservata: i pipistrelli. Per questi mammiferi alati le bolle rappresentano l’unica fonte d’acqua della zona, visto che il fiume Breggia per loro è poco accessibile a causa delle sue caratteristiche torrentizie. Nelle prime ore della notte le bolle vengono quindi visitate in massa da tutti i pipistrelli che trovano rifugio o cacciano in Valle di Muggio. Tra la decina di specie già osservate sulle bolle tra il Dosso dell’Ora e il Dosso Bello spiccano il Vespertilio maggiore (Myotis myotis) e il Vespertilio minore (Myotis blythi) che sono due dei pipistrelli più rari del nostro Cantone."
Tratto da: Mattei-Roesli, Marzia e Tiziano Maddalena, "Zone umide: perle rare", in Valle di Muggio allo specchio. Paesaggio incantevole, paesaggio mutevole, a cura di Paolo e Silvia Crivelli, MEVM ; Fondazione Ticino Nostro, 2017, pp. 81-87.